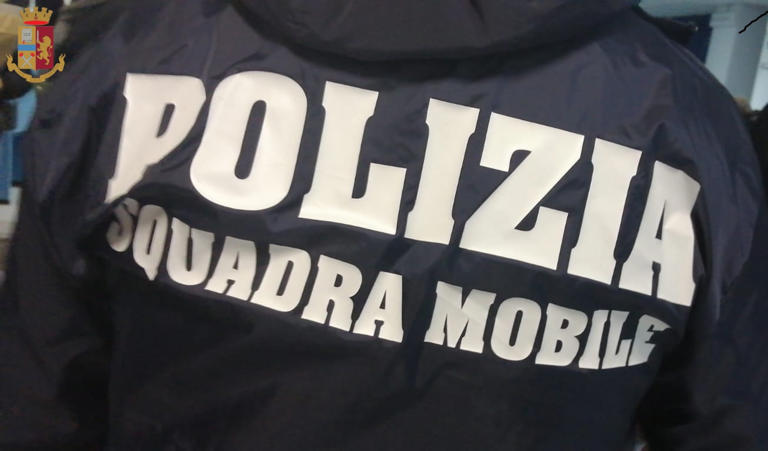Armi, ipocrisia e affari: il doppio volto del Canada nel conflitto israelo-palestinese
Il governo di Ottawa promette trasparenza e giustizia, ma continua ad alimentare la macchina bellica israeliana. Un nuovo rapporto smonta la narrazione ufficiale e rivela la filiera nascosta del commercio militare canadese.
Da mesi il Canada sbandiera il proprio impegno a favore della pace e della legalità internazionale. Dopo l’escalation a Gaza iniziata nell’ottobre 2023, il governo di Justin Trudeau aveva annunciato il blocco dei nuovi permessi di esportazione di armi verso Israele. Una decisione apparsa come segnale politico, dettato anche dalla crescente pressione interna di un’opinione pubblica sempre più critica. Ma la realtà è ben diversa.
Secondo un rapporto pubblicato da Palestinian Youth Movement, World Beyond War e Arms Embargo Now, non solo le forniture militari dal Canada a Israele non si sono mai fermate, ma si sarebbero persino intensificate. Le spedizioni sono avvenute tramite permessi pregressi o addirittura attraverso triangolazioni con gli Stati Uniti, sfruttando scappatoie legali che consentono di eludere i divieti ufficiali.
Le cifre dietro la retorica
Il documento parla chiaro: oltre 390 spedizioni da 21 produttori in sei città canadesi, per un totale di centinaia di migliaia di proiettili, componenti per jet F-35, radar, sensori e tecnologie dual use come antenne GPS. I beneficiari? Le principali industrie militari israeliane, da Elbit Systems a Snunit Aviation.
I tre principali fornitori canadesi – Stelia, CMC e Nexeya – producono componenti vitali per il caccia F-35, considerato l’asset strategico dell’aviazione israeliana. Secondo il rapporto, ogni F-35 impiegato da Israele contiene almeno 2,1 milioni di dollari in componenti realizzati in Canada. Senza queste forniture, gran parte della flotta aerea israeliana sarebbe tecnicamente compromessa.
Il 13 luglio 2024, uno di questi caccia è stato impiegato per bombardare al-Mawasi, zona designata come “area sicura” nella Striscia di Gaza: 90 morti e oltre 300 feriti. Un raid che coinvolge anche responsabilità indirette, ma concrete, dei Paesi produttori.
Industria e politica: un cortocircuito pericoloso
Il cuore della questione è il sistema di autorizzazione canadese: i permessi, firmati dal ministro degli Esteri, restano validi anche dopo il mutamento del contesto bellico, permettendo la prosecuzione degli scambi. In almeno 67 casi, componenti militari sono stati trasportati su voli passeggeri – Lufthansa, Air Canada, Air France – trasformando rotte civili in corridoi bellici.
Oltre alla responsabilità morale e politica, si apre così un problema legale: il Canada, firmatario del Trattato sul commercio delle armi (ATT), è vincolato a interrompere le esportazioni verso Paesi coinvolti in gravi violazioni del diritto internazionale. La Corte Penale Internazionale ha avviato indagini sul comportamento israeliano a Gaza. Continuare a fornire armamenti significa esporsi a future contestazioni giuridiche.
Geopolitica delle armi e diplomazia selettiva
Il Canada, membro del G7 e tra i principali partner della NATO, coltiva l’immagine di “potenza gentile”. Ma il suo ruolo nel sostegno all’industria militare israeliana racconta un’altra storia: quella di un Paese che antepone l’interesse industriale alla coerenza diplomatica.
Il rapporto non si limita a denunciare. Chiede un embargo totale, la revoca immediata di tutti i permessi attivi, la chiusura delle triangolazioni USA, il blocco delle tecnologie a doppio uso e lo stop agli acquisti di armamenti testati in battaglia contro i civili palestinesi.
In un mondo che invoca regole comuni, la forza della verità risiede nella trasparenza. E oggi quella trasparenza impone al Canada – e a tutti gli attori simili – di scegliere: legalità o complicità.
L’articolo Armi, ipocrisia e affari: il doppio volto del Canada nel conflitto israelo-palestinese proviene da InsideOver.
Perché il silenzio dell’Europa sulla guerra a Gaza è (anche) colpa di von der Leyen
Roma, 5 agosto 2025 – Secondo Nicolas Schmit, ex commissario europeo, l’incertezza mostrata dall’Unione europea sulla guerra a Gaza non nasce solo da divergenze politiche tra gli Stati membri, ma da una più profonda incapacità istituzionale, aggravata dal forte accentramento del potere nelle mani della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. In un’intervista rilasciata a The Capitals, Schmit ha raccontato che per oltre un anno dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, la Commissione non ha mai affrontato seriamente la questione del rapporto tra Ue e Israele. A suo dire, non è mai stato aperto un vero confronto strategico interno alla Commissione, né si è discusso di visioni alternative sulla questione mediorientale.
La linea adottata sarebbe stata fortemente influenzata dalla posizione filo-israeliana assunta da von der Leyen, allineata con quella di Berlino e Washington, che avrebbe lasciato poco spazio ad altri punti di vista. Schmit ha sostenuto che, senza una posizione comune elaborata in modo collettivo, la Commissione ha finito per agire in modo disorganizzato e reattivo, limitandosi a esprimere compassione verso i civili palestinesi ma senza interventi concreti. Il mandato di Schmit, che ha ricoperto il ruolo di commissario per il Lavoro e i Diritti sociali fino alla fine del 2024, si è concluso da pochi mesi. Le sue critiche si aggiungono a quelle dell’ex alto rappresentante Josep Borrell, che aveva definito l’atteggiamento dell’Ue ‘complice’ rispetto ai crimini di guerra israeliani.
Anche Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione e esponente del governo spagnolo, ha dichiarato di aver sollecitato von der Leyen ad assumere una posizione più ferma. Nonostante la sua vicinanza a Paesi molto critici verso Israele, come il Lussemburgo, Schmit ha preso le distanze dalle parole più dure di Borrell, attribuendo il comportamento della Commissione non a complicità ma a debolezza politica. Recentemente, gli Stati membri hanno discusso la possibilità di escludere Israele dal programma di ricerca europeo Horizon Europe, una misura che segnerebbe la prima vera sanzione Ue dall’inizio della guerra. Tuttavia, la proposta non ha ottenuto il sostegno necessario: se da un lato Francia, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Belgio si sono detti favorevoli, altri come Austria, Ungheria e Repubblica Ceca si sono opposti, mentre Germania e Italia hanno chiesto più tempo.
Schmit ritiene che la situazione a Gaza sia ormai talmente grave da non poter più essere ignorata dall’Europa. Pur evitando di entrare nel dibattito giuridico sul genocidio, ha affermato che la realtà sul campo è prossima a quel livello. Secondo lui, la sospensione di Israele da Horizon Europe avrebbe un impatto limitato. Al contrario, propone di congelare l’Accordo di associazione tra Ue e Israele, considerato l’unico vero strumento politico e diplomatico a disposizione dell’Unione per esercitare pressione.
Infine, Schmit ha ampliato la sua critica all’operato generale della presidente von der Leyen, accusandola di avere centralizzato il potere al punto da impedire qualsiasi reale confronto politico all’interno della Commissione. Questo, secondo lui, ha soffocato il dibattito strategico e compromesso l’efficacia dell’azione europea su più fronti. Aveva già espresso queste preoccupazioni durante la sua fallita candidatura alla presidenza della Commissione nel 2024.
Tra export e riarmo, la corsa senza limiti dell’industria italiana della Difesa
L’industria della difesa italiana ricopre un ruolo di primo piano nello scacchiere internazionale e si prepara, complice la stabilizzazione della conflittualità in Europa, in Medio Oriente e in altre zone calde del globo, a una repentina fase di espansione. Nell’inconsapevolezza (quasi) totale dell’opinione pubblica autoctona, l’Italia è assurta negli ultimi anni a sesto esportatore mondiale di armamenti. Nell’ultimo elaborato del SIPRI – Stockholm International Peace Reasearch Institute – sul trasferimento delle principali armi convenzionali nel quinquennio 2020-2024, il Belpaese si posiziona dietro le principali potenze segnanti la nostra epoca (Stati Uniti, Francia, Russia, Cina e Germania), davanti a imperi che tentano con ogni mezzo di posticipare l’inesorabile tramonto (Gran Bretagna e Spagna) e a quanti, invece, sono pronti a godersi una nuova alba (Turchia).
Roma copre oggi il 4.8% (Pechino il 5.9%, Mosca il 7.8%) delle esportazioni sul totale del mercato degli armamenti a livello mondiale. Nel periodo precedente preso in osservazione dal SIPRI, il 2015-2019, tale valore era appena al 2%. L’invasione russa su larga scala dell’Ucraina nel febbraio del 2022, l’attacco non convenzionale di Hamas a Israele il 7 ottobre e quanto seguito dopo, hanno, necessariamente, imposto una maggiore prontezza al sistema industriale bellico italiano. Tuttavia questi eventi, pur nella loro indiscussa rilevanza, non paiono in grado di “giustificare” un incremento delle attività pari al 138%. Altri fattori concorrono all’exploit militare-industriale italiano, su tutti la penetrazione di nuovi mercati dal potenziale ancora inespresso ma in forte ascesa (Sud-Est asiatico) e la modernizzazione delle Forze Armate italiane.
Incrociando le informazioni ricavabili dall’elaborato del SIPRI e dalla Relazione annuale sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per l’anno 2024, emerge il quadro della situazione italiana. L’Italia ha esportato effettivamente armamenti per 4.5 miliardi di euro, con un incremento del 14,51% rispetto ai 3.9 dell’anno precedente. Sono arrivati a 90, prima erano 83, i Paesi autorizzati all’importazioni di armamenti italiani e il numero complessivo delle autorizzazioni è passato da 2101 a 2569. Dei 4.5 miliardi di euro esportati il 33% è stato diretto in Medio Oriente, il 31% verso Paesi aderenti all’Unione Europea o all’Alleanza Atlantica, un 15 % in Asia e un 8,5% verso Paesi in Europa ma non facenti parte di Ue o Nato.
I maggiori clienti in Medio Oriente e Asia
Le prime 15 società esportatrici in questo settore hanno assorbito all’incirca l’89% del totale delle operazioni svolte l’anno precedente. Le prime due, però, giocano una partita tutta loro. Solamente sommando il peso finanziario di Leonardo (27.67%) e quello di Fincantieri (22,62%) nell’ammontare delle esportazioni totali, si evince il loro determinante peso nel trainare l’intero comparto bellico italiano.
Per il SIPRI, nel periodo 2020-2024, i principali destinatari di armamenti italiani sono stati, rispettivamente, Qatar, Kuwait ed Egitto. Tali cifre vengono parzialmente confermate dalla Relazione annuale, la quale per il 2024 evidenzia esportazioni in Qatar per 548 milioni di euro, seguìto dal Kuwait a 534 e infine il Regno Unito a 461. Qatar e Kuwait, fra i maggiori acquirenti di armamenti a livello globale, guardano da almeno un decennio a Roma per modernizzare la propria Aeronautica e Marina.
A questi dati vanno, per avere una visione più organica e dinamica, aggiunti anche gli ordini effettuati ma non ancora consegnati, i quali garantiranno nel prossimo futuro una certa continuità nella crescita del sistema industriale italiano. Il caso dell’Indonesia è emblematico. Giacarta nel marzo del 2024 ha firmato un contratto con Fincantieri per l’acquisto di due unità di Pattugliatori Polivalenti d’Altura per 1,18 miliardi di euro. In aggiunta continuano a circolare voci, per il momento non ancora smentite, di un forte interesse indonesiano per l’acquisto della portaerei Garibaldi, la prima portaerei costruita dall’Italia nel dopoguerra, oggi “pensionata”.
Nel prossimo futuro è lecito aspettarsi la comparsa dell’Arabia Saudita sul podio dei principali acquirenti di armamenti italiani. In seguito alla visita di Stato del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Arabia Saudita lo scorso gennaio, sono stati firmati dei memorandum tra il regno saudita e Leonardo e Fincantieri che aumenteranno sensibilmente la cooperazione nei settori aerospaziale, cantieristico-navale e della difesa. Gli anni in cui Roma dichiarava l’embargo verso Riyadh paiono appartenere a un’era geopolitica fa.
La sfida cui oggi l’industria della Difesa italiana è chiamata a rispondere nasce dall’esigenza di un cambio di approccio, da mercantilistico a strategico. Da strumento volto (prevalentemente) a inserirsi e acquisire influenza nei vari mercati, a mezzo per garantire (soprattutto) alle Forze Armate italiane tutte le componenti indispensabili per far fronte al processo di ammodernamento. Nonostante la politica di riarmo nazionale coinvolga i vari Paesi europei, “l’industria della difesa europea” rimane estremamente frammentata. Per accaparrarsi i migliori contratti assisteremo a una sfida fra Italia, Germania, Francia e Regno Unito con possibili colpi di scena. Sarà, quindi, in grado l’Italia e la sua industria a continuare ad aumentare i ricavi dalle esportazioni di armamenti in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico, oppure i rifornimenti richiesti dalle Forze Armate italiane e dai principali Paesi europei assorbiranno una buona parte degli ordini?
Tutto quello che non torna nel caso Almasri
Perché Njeem Osama Almasri è stato liberato? Chi ha sbagliato tra il 18 e il 20 gennaio di quest’anno? Proviamo a ricostruire tutta la vicenda del super-ricercato dalla Corte penale internazionale, del suo strano viaggio indisturbato in Europa e del suo ritorno in Libia sul Falcon di Stato.
Il 2 ottobre dell’anno scorso il Procuratore della Cpi Kamir Khan (oggi nei guai per una storiella piccante) chiede ai giudici dell’Aja di chiedere la cattura del comandante della terribile milizia salafita Rada per le torture e le violenze compiute da direttore del carcere di Mittiga su una cinquantina di detenuti. La Corte si prende del tempo ma il sei gennaio il libico arriva a Londra da Tripoli via Fiumicino, dove secondo il Telegraph vede i legali a Chinatown e dove chiederà (invano) ai nostri 007 di essere estradato. Solo il 18 l’Aja emetterà il verdetto, presa a maggioranza (due giudici a uno) dai tre magistrati della Pre-trial chamber: la romena Ioana Antonella Motoc, la beninense Reine Alapini-Gansou e la messicana Maria del Socorro Flores, contraria.
Intanto l’intelligence della Corte lo segue, grazie alla rete tra diplomazie, servizi e Interpol. Il 13 gennaio Almasri va a Bruxelles, prosegue in Germania (dove resta tre giorni) tra Bonn e Monaco di Baviera, la polizia tedesca lo ferma per un controllo di routine e lo lascia andare, sebbene dal 10 luglio 2024 sia attenzionato dalla blue notice dell’Interpol visibile solo a Berlino. L’Aja ne viene informata e allerta Belgio, Regno Unito, Austria, Svizzera e Francia, non l’Italia dove i tedeschi sapevano che fosse diretto. Perché? Siamo al 16 gennaio, Almasri passa da Francia, Olanda e Svizzera indenne: sabato 18 in Mercedes viaggia in direzione Torino per la partita Juve-Milan, prima del volo di ritorno a Tripoli da Fiumicino che non prenderà mai. Intanto la Corte decide la sua cattura, alle 22.55 di sabato mentre è allo stadio. Viene spiccato il mandato, la Digos di Torino lo arresta in hotel quando sono le tre del mattino, assieme ai tre amici con lui.
E qui il giallo si infittisce. Domenica 19 ministero della Giustizia viene informato, lo staff del Guardasigilli Carlo Nordio – lo dice uno scambio di email tra il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e il responsabile del Dag Luigi Birritteri delle 14.35 del 19 – chiamano fuori dalla contesa Via Arenula, tanto che il Guardasigilli viene formalmente informato solo il giorno dopo, quando però il Pg chiede di dichiarare l’irritualità dell’arresto in quanto non preceduto “dalle interlocuzioni con Nordio, titolare dei rapporti in via esclusiva con l’Aja”. Ma a essere concordata tra ministero e Corte penale è la “consegna” del criminale, prevista dall’articolo 11 della legge 237 del 2012, tanto che l’articolo 716 del Codice di procedura penale avrebbe consentito di congelare il fermo. L’iter della legge è preciso: il Pg “chiede” la misura cautelare, la Corte d’Appello “la applica”, il ministro ha tempo 20 giorni per la consegna. “Il governo ha potuto espellerlo perché Pg e Corte d’Appello non hanno osservato la legge che avrebbe imposto la misura cautelare”, dice al Giornale l’ex numero due all’Aja Cuno Tarfusser.